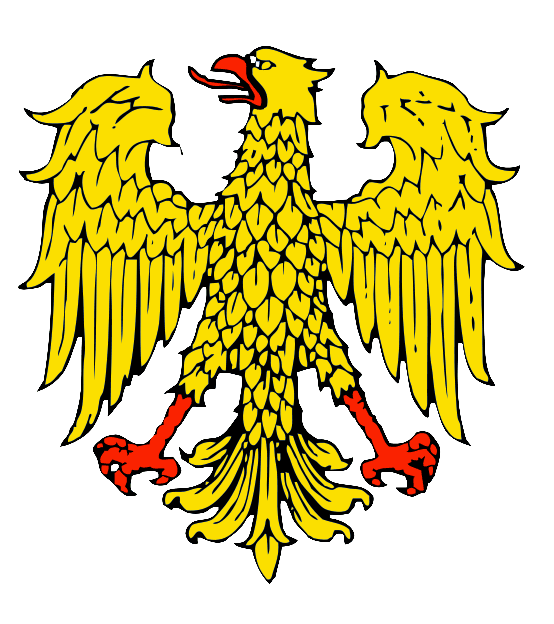RENATO APPI
 APPI RENATO (1923 – 1991) da DIZIONARIO BIOGRAFICO dei FRIULANI
APPI RENATO (1923 – 1991) da DIZIONARIO BIOGRAFICO dei FRIULANI
Impiegato alla Cartiera Galvani, per lunghi anni vicepresidente della Società filologica friulana (dal 1974) e dell’Ente Friuli nel mondo (dal 1977), Appi (Cordenons, 1923 – Pordenone, 1991) fu «un entusiasta con tratti utopistici e quasi adolescenziali, un animatore instancabile» (Ciceri).
Tra le associazioni da lui promosse “Il cjavedàl” di Cordenons. Appi combatté in Francia dove fu fatto prigioniero e rinchiuso in un campo di concentramento, da dove evase tre volte, l’ultima con successo. Decisiva anche per la scrittura l’esperienza della prigionia a Trier (Treviri), tra il 1943 e il 1944, esperienza che A. rievocherà in anni maturi: «Ad appena vent’anni ero prigioniero di guerra in Germania.
Nell’incertezza del domani, nelle privazioni, nella solitudine, nella sofferenza, che tale stato comportava, il pensiero andava costantemente alla casa lontana, ai familiari, agli amici che si temeva di non poter più rivedere. E si viveva di ricordi. Erano costantemente presenti alla memoria soprattutto i giorni felici dell’infanzia», e dell’infanzia si riversano sulla pagina i risvolti favolosi. Ma importa la ricaduta della lingua: «E con i ricordi dei luoghi e delle persone ritornavano le voci e il loro suono diventava onda, ritmo, cantava dentro e si faceva poesia». Il friulano (il friulano di Cordenons, ai margini del dominio) come nicchia e rifugio, appartenenza e cornice condivisa.
Per quanto il codice materno di Appi «non fosse il dialetto friulano e contadino di Cordenons, ma il veneto ripulito della borghesia locale» (Rizzolatti). Il «paese» come maglia profonda e il friulano come suo specchio saranno una conquista graduale, anche se il bilancio potrà dichiarare: «Il rapporto, la magìa instauratasi allora hanno continuato, attraverso gli anni, a legare il mio animo ai suoni musicali della mia parlata, che è quella dei miei cari, dei miei avi, dei miei amici, della mia terra». Nel 1945, al rientro dalla prigionia, A. mette in scena Ritorno alla vita, un dramma in italiano (con inevitabili e scolastiche ingenuità: «esecrata baracca», «Evadere da questo misero luogo, rompere le catene che ci serrano e andare incontro a quegli occhi che laggiù ti chiamano…»), che dà spazio a crudi inserti tedeschi, a rendere (anche acusticamente) l’urto del campo.
Il titolo sembrerebbe additare la fine delle costrizioni e investe per contro un perimetro tutto interiore: il recupero di una speranza, di una fiducia, che si erano inaridite. Ma importa isolare: «Se ho un attimo di abbandono, scrivo e dimentico tutto. Scrivendo, ritrovo me stesso, quale ero e quale sono, per vivere, entro di me, la vita che qui non posso, ma che vorrei vivere». La scrittura come surrogato e terapia, ma anche come urgenza, bisogno insopprimibile. Dal 1945 si snoda l’attività teatrale, che ad A. ha procurato i riconoscimenti più limpidi: un doppio percorso, perché all’italiano si affianca ben presto il friulano. Del 1946 è Dividèn la proprietàt [Dividiamo la proprietà], cui si aggregherà due anni dopo, a dittico ed epilogo, ’Na Pasca in tribunal [Una Pasqua in tribunale], due commedie non senza implicazioni ridicolose, che si avvalgono di risorse onomastiche (Emilio Trufaldìn, veterinario e giudice conciliatore), oltre che linguistiche (l’italiano che si intercala con il friulano in un personaggio inurbato a Milano, con prevedibili sussieghi). E sfruttano luoghi comuni: il sensale imbroglione, l’avvocato ubriacone, i battibecchi tra moglie e marito. Affiora la modernità (un trattore), la cronaca, ma la piega è farsesca, a sopprimere quanto di drammatico si annida nei due titoli, a esorcizzare l’angoscia di un universo lacerato e rivolto, che si imporrà poi, cifra complessiva e alta dell’autore. Cuore dell’esistenza contadina è la famiglia unita, tesa a crescere numerosa, la proprietà compatta, tesa ad allargarsi, e pertanto produce strappi insanabili la divisione dei beni, come la partenza dei figli. La corda del primo A. friulano è estrosa, ma già solida e strutturata è la fisionomia linguistica: nei suoi intercalari («pangilingua»), nelle sue tessere lessicali («spacanulis», gradasso, «zornà», ronzare, corteggiare). Nei suoi modi di dire: «Ma la tiara ’a èis bassa, tant bassa» [Ma la terra è bassa, tanto bassa], sintesi di una fatica grama, di una dignità dolente, qui ancora immersa nella dinamica del sorriso. Tra i due testi friulani si incunea Il sogno di Spazzacamino, commedia musicale per bambini del 1947, in agili versi rimati (dove è sensibile il gusto dell’apocope: «L’inverno che vien accresce nel cuor / l’acre desir di un focolar…»). Spazzacamino, orfano e sperduto, la notte di Natale sogna doni e le carezze della madre, e a Natale sarà ospite di una bambina sensibile, a dispetto della ostilità di un fratello, e della sua famiglia. La favola, con ovvia filigrana pedagogica, non manca di sottolineare l’antitesi fra bene e male, ma è precisa la consegna ideologica: «Sai c’è sempre qualche cosa: / s’alza il sole e si lavora, / cala il sole e si riposa; / chi dispera si rincuora, / chi…», «Spazzacamino / non può avere un casolar, / ma, se questo è il mio destino, / nulla vale ad imprecar!». Sono gli anni del lodo De Gasperi, delle lotte dei braccianti nel Sanvitese, che in Pasolini maturano una più chiara coscienza politica. Il teatro italiano di A. si stacca dalle atmosfere paesane, dalla terra e dalla precarietà della sua economia, dalla severa norma etica che impone. Risale al 1948-1949 La casa di cartapesta (a stampa nel 1952), un dramma che sfalda i contorni, con una pioggia battente come colonna sonora e minaccia, con un assunto inquietante: «La casa di un morto mai potrà appartenere interamente ad un vivo. Solo le idee restano. I fatti lo dimostrano». Emilio, senza mezzi, investe le proprie aspirazioni in una casa. Enrico, banchiere e suo datore di lavoro, gli sottrae i progetti, lo licenzia e costruisce la casa vicino al fiume. Emilio, per salvare il proprio cane, viene travolto dal fiume in piena. Il cane sarà eco ossessiva. Enrico spara al cane ed è inghiottito, con la casa, dal fiume di nuovo in piena. Questa è la trama ridotta a sequenza lineare, risolvendo il taciuto, il rimosso, in un paesaggio che di nitido ha solo l’argine enorme del fiume, dove i rapporti si sgretolano, dove il passato incombe enigmatico e distruttivo. La rivista veneziana «Teatro del giorno» aveva già accolto nel 1951 il radiodramma Nel roccolo, poi messo in onda da Radio Capodistria e da Radio Trieste, metafora del campo di concentramento e della vita, un allusivo ritorno da un «laggiù» indefinito, una nebbia che cancella prospettive e certezze, dove i personaggi perdono l’identità anagrafica, per diventare «L’uomo», «L’amico», «Donna». Nel 1955 si colloca È poco un sole per Valschiuma. Una grande casa, l’istanza di una grande famiglia, ma insediata nel bosco, a respingere ogni forma di contatto, a estraniarsi da ogni rete sociale: «Quaggiù, in questo mondo di spiriti, fra nebbia e nebbia, si vive e non si sa di vivere: ci si guarda e non ci si riconosce: come bestie!». E, nel bordone del vento, una attesa perenne (uno dei figli se n’è andato): «Deve venir domani. E siamo appena a sera. E ci sarà un domani, un dopodomani e un dopodomani ancora, tutti da venire. Lo capisci che non si può non aspettare? Tutti aspettano». En attendant Godot di Beckett è della fine degli anni Quaranta, l’edizione francese del 1952, il primo allestimento a Parigi nel 1953, a fissare una (per quanto precaria) griglia sinottica, che peraltro non intende affiliare A. al teatro dell’assurdo. Chiude la trafila italiana un altro radiodramma, Gli occhi sulla nuca, del 1958, trasmesso da Radio Capodistria nel 1959 e da Radio Trieste nel 1974, dove la percussione acustica (il tic-tac del pendolo, i clacson, il movimento del tergicristallo) scandisce lo scorrere del tempo, che accompagna e sollecita l’aggallare dei ricordi, in un ellittico sovrapporsi di piani: un interrogatorio, una evasione dislocata nel passato, un incidente automobilistico, episodi ovattati in un filo di delirio, con comparse e protagonisti ridotti a maschera («L’Uomo», «Il Brigadiere», «Il Comandante», «Il Medico»). Pur tecnicamente scaltriti nel ricorso al flashback, ad altri paradigmi si rifanno, con caparbia intensità, i testi friulani. Nel 1957 risulta vincitore del concorso della Filologica L’ultin perdòn [L’ultimo perdono], che la giuria, composta da Ciro Bortolotti, Pietro Someda de Marco e Carlo Mutinelli, valuta «Lavoro forte, ben costruito, sì da rivelare mano esperta di teatro, con situazioni logiche ed umane, legate da un afflato di poesia, triste, ma genuina», «il più importante e robusto lavoro, fino ad ora, scritto per il teatro friulano». La vicenda si sgrana in un protratto intervallo di anni, impastata di rigide norme etiche e non senza contorni favolosi, come la «montagna verda» che con il suo canto annuncia sventure. Mentre infuria la bufera e si dispiega il canto della montagna, un padre mette alla porta la figlia incinta di un mascalzone, a sua volta suicida. La donna si consumerà negli stenti e il piccolo ignaro consegnerà al nonno l’ultimo perdono, ma, una volta cresciuto, emigrerà oltreoceano. L’intransigenza del padre si compendia in un proverbio: «A mi me basta che al cuarnolàr a nol fei piàrsui» [A me basta che il corniolo non frutti pesche], ma il tragico leitmotiv che attraversa il testo, prima indizio e poi sigillo, è «La ciasa ’a è granda, ma ’a è guoita!» [La casa è grande, ma è vuota!], ad archiviare un mondo che sulla casa (sulla casa grande) aveva avuto il suo asse. In Jò e te [Io e te], che nel 1962 si aggiudica il concorso della Filologica, l’ottica di chi resta si scontra con l’ottica di chi va e inconciliabili sono gli assiomi che cristallizzano: «Oltri al truòi al mondu al è negri» [Oltre il sentiero il mondo è buio], «Oltri al truoi, tra i alnàrs, lì ’a è la vita» [Oltre il sentiero, tra gli ontani, lì è la vita]. I piani temporali si incrociano tra la condizione in atto e allucinati recuperi del passato: tra la «biela famèa granda» di ieri e la «meseria granda» di oggi. Le risorse che mancano, le braccia che non reggono, mentre «Fòur pal mondu, jo pensi, un bocòn da mangià a se lu ciàta sempri, s’al è gola da lavorà» [Nel mondo, penso, un boccone da mangiare si trova sempre, se si ha voglia di lavorare], ma all’ipotesi reagisce il muro dell’istinto, la tenuta strenua della coppia, che fa barriera. A dominare è l’ideologia cocciuta dell’ostrica, non casualmente affidata al verbo «stringere»: «adès te siàris al pui; un pui de tiara te lu strens sempri. Te lavoris e te mangis. Viars al pui, lassa la tiara e no te strenzaràs pì nia, mai!» [adesso chiudi il pugno; un pugno di terra lo stringi sempre. Lavori e mangi. Apri il pugno, lascia la terra e non stringerai più niente, mai!]. E, verghianamente, il contrappunto proverbiale marca di assoluto, di atemporalità, il principio testardo, appassionato e malinconicamente fallimentare della fedeltà: «Ogni gambiada ’na brusada» [Ogni cambiamento una bruciatura]. Nel 1965 A. realizza l’impresa di un primo e terzo premio al concorso della Filologica con De ca e de là [Di qua e di là] e Stòriis dal gno paîs [Storie del mio paese], che di fatto esauriscono la parabola del suo teatro friulano, toccandone il vertice con De ca e de là, dove si registra non il destino greve di chi rimane, ma la sorte dell’emigrato. Un emigrato che ha fatto fortuna, dopo essersi sottoposto alla sequela dei lavori più penosi senza cedere: «Da crevàssi, sigùr, ma no ‘dago’! Murì pituòst!» [Da spezzarsi, sicuro, ma non “dago”! Morire piuttosto!], nell’aura del successo e del sacrificio più ostinato. Nello spezzone ha rilievo il forestierismo, un insulto infamante. Altri sintagmi stranieri occhieggiano nel testo: «Ah, forget it!» [Ah, non pensarci!], «Shut up» [Taci], nel cerchio della rinuncia, della parola ingoiata, cui corrispondono analoghe formule friulane, grumo di sapienza, come «Lassàn piàrdi» [Lasciamo perdere], «No sta pensà» [Non pensare]. In De ca e de là si incidono lacerti della vita «de là», del paese di arrivo, ma soprattutto i mutamenti «de ca», del paese d’origine, dove il non conoscere più nessuno innesca l’incubo di un «paèis guoit» [paese vuoto]. Una doppia perdita di identità: «A se è ca e de là come un vivi sdoplàt ch’a nol se cueta» [Si è qui e là come un vivere doppio che non si placa]. Una elegia amara, dura. In Stòriis dal gno paîs A. impiega, eccezionalmente, il friulano centrale: «un dramma impostato tutto su una accesa tensione lirica» (così la giuria formata da Ciro Nigris, Rodolfo Castiglione e Cesare Milanese). Un «paîs» al limite della chiostra alpina, un capocontrada, un coro di donne (le vecchie in nero, le giovani in bianco), una madre in attesa del figlio soldato, figure senza volto. Con attimi di abbandono («E odôr di altiûl, / di pestelàcs, / di nasebon, / pai praz dal nûl…», E odore di fieno all’ultimo taglio, / di primule, / di profumo, / nei prati delle nuvole…), ma con il brivido della montagna che si accende di fuochi, che i lampi rendono verde, e del coro dei soldati morti che cantano «Sul ponte di Perati…». A una forma particolare di teatro A. tornerà solo con le dodici (Tredici meno uno: è l’ammiccante etichetta di Angela Felice) «radioscene» di Vere o no vere [Vero o non vero], trasmesse da Radio Trieste nel 1974-1975, nelle quali A. sfrutta altre varietà di friulano (oltre a Cordenons, Azzano Decimo, Budoia, Castel d’Aviano e Arzene), per esplorare l’universo delle superstizioni, in bilico tra razionalità sorniona e implicazione residua: a tavola non ci si siede in tredici, non ci si mette in viaggio di venerdì, il cappello sul letto porta disgrazia, come il gatto nero che attraversa la strada, e via via. Le «radioscene» annettono proverbi e modi dire («Sentì el mane che ’l dis mal de la manera!», Sentire il manico che dice male della mannaia!) e fanno mostra di una non comune competenza linguistica, come nella lista dei funghi («no te ciate un barbagnòt, ’na ciarta rossa, ’na bala dardana, un roan o un pitaròl nìncia a fà chilometri!», non trovi un porcino, un prataiolo, un ovolo, una russula o un gallinaccio neanche a fare chilometri!, per Budoia). Si svolgono leggere e non prevedono scavi psicologici: «prive di intendimenti drammatici, ma non prive di una grazia e di un’arguzia popolaresca che le lega direttamente alla tradizione dei dialoghi e dei contrasti collorediani» (Rizzolatti). E postulano un lungo tirocinio nell’ambito della cultura popolare. A. è stato raccoglitore dell’Atlante linguistico friulano, ha allestito Aggiunte al «Nuovo Pirona» per l’area di Budoia (1970, con la moglie Elvia e Umberto Sanson) e per la Valcellina (1973, con la moglie), e numerosi sono i contributi sulla Bassa, sul Livenza, sulla zona di Aviano, Palmanova, Pordenone, su Cordenons, Lucinico, San Michele, San Vito al Tagliamento. Ad A. (ancora in collaborazione) si deve un ragguardevole corpus di racconti popolari per Aviano (1972), Azzano Decimo (1975), Budoia (1971 e 1999), Coltura (1973), Concordia Sagittaria (1969), Cordenons (1968 e 1971), Mezzomonte (1973), Montereale Valcellina (1978) e Polcenigo (1972), volumi confluiti in una collana della Filologica: un patrimonio per la narrativa e per le varietà linguistiche che documentano. Altri campi di indagine (sempre a più mani) sono le piante nell’uso popolare (1979 e 1983) e la pietà popolare (1990 e, postumo, 1992), con censimenti sistematici dall’ancona di pregio al capitello più modesto. Se il teatro si dispone in tracciati paralleli (italiano e friulano), rispetto al teatro gli interessi etnografici articolano un segmento consecutivo, mentre lungo l’intero arco si distribuiscono i versi e i racconti, che intersecano anche i temi del teatro, per sconfinare nell’aneddoto minuto, nella amenità curiosa, nella increspatura burlesca. Il perimetro contadino minato dai flussi migratori, la difficile transizione dai campi (poveri ma sicuri) alla fabbrica (più miraggio che realtà domata), con i corollari di destini agri, esistenze tormentate. Una umanità dolente, «corposa», assorta in un «ritmo di pensieri che non sono neppure un monologo interiore, quasi neppure la coscienza dei moti dell’animo» (Ciceri), a dispetto di una frase breve, di una paratassi marcata. Con snodi che rinviano a Jò e te: «Ara, semèna, séa, restelèa e po mena a ciasa. La tiara ’a è bassa, ma generosa, largia cun chi ch’a la lavora!» [Ara, semina, falcia, rastrella e poi porta a casa. La terra è bassa, ma generosa, larga con chi la lavora!], «Bisugna strenzi la tiara, siarà al pui e muàrzela fin a ridùsela in pòlvera» [Bisogna stringere la terra, chiudere il pugno e morderla fino a ridurla in polvere], a condensare in una doppia epigrafe una ideologia e il suo epicedio. E nel sentimento del tempo filtrano scaglie condivise con i versi: «I dis ch’a ne reparin a’ son àgrimis disculuridis dal timp, gotis de memoria ch’a colin dal dì che sen nassùs, tal rosari dei nuòstris pas, come perlis claris ch’a rilusin delunc via!» [I giorni che ci proteggono sono lacrime scolorite dal tempo, gocce di memoria che cadono dal giorno in cui siamo nati, nel rosario dei nostri passi, come perle chiare che brillano per quanto si distende la loro durata!]. I versi si dispongono in due blocchi: Chel fantassút descòls [Quel ragazzetto scalzo], del 1969, in edizione accresciuta nel 1975, con il corredo delle incisioni di Virgilio Tramontin, e Come dal Purgatoriu [Come dal Purgatorio], del 1984, con a fronte, in un dialogo serrato, i disegni di Anzil, ai quali si accoda un consistente fascio di testi dispersi o inediti. «È un dettato, il suo, che indubbiamente richiama Pasolini» (Giacomini): per contiguità di percorso, per isolate convergenze tematiche, per il fascino di un friulano eccentrico. Ma la difformità non è di dettaglio, anche se il dettaglio ne esalta lo spessore. Come la pratica del tradurre in friulano, per Pasolini il «passo più probatorio per una sua promozione a lingua» (e all’origine di splendidi esercizi), mentre in A. produce un unico episodio, quasi fortuito, indotto dalla regia di Andreina Ciceri (in un fascicolo di «Sot la nape» del 1957). Agli alessandrini di un Rimbaud sedicenne (Sensation è del marzo 1870), «Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, / Picoté par les blés, fouler l’herbe menue…» [Nelle sere blu d’estate, andrò per i sentieri, / punto dal grano, a calpestare l’erba sottile…], A. risponde con «Tal scur da lis seris d’istàt, zirai pai truòis, / Seghetàt dai furmins, a pestâ al strafuòi…» [Nel buio delle sere d’estate, andrò per i sentieri, / tagliuzzato dai frumenti, a calpestare il trifoglio…]. Con accortezza di artifici, come il dispositivo della rima baciata («truòis» : «strafuòi», con dovizia di echi fonici), come la stessa rima interna («istàt» : «Seghetàt», che rimodula il paronomastico «bleus» : «blés» dell’originale), ma senza sviluppi (e senza responsabilità) ulteriori. Il plurilinguismo del secondo Pasolini non ha riscontro in A. poeta, che si concede una sola escursione significativa in gravisano per la morte di Biagio Marin. E non declina sintonie la metrica: sofisticati schemi chiusi in Pasolini, in A. un ordito tendenzialmente aperto, anche se un contatto è garantito dalla concitazione dello «spiritual», per il quale è verosimile una dipendenza dal Pasolini di Dov’è la mia patria. Pur se l’icona del «fantassút descòls» evoca analoghe epifanie pasoliniane e prossime a Pasolini risultano scorci come «Sunàt ciampànis…» [Suonate campane…] o (e meglio) «Eri un fivuòl ch’al veva gust de vivi…» [Ero un bambino che aveva il gusto di vivere…], da accostare a «El jera un fiol ch’el veva sogni…» [Era un ragazzo che aveva sogni…] di Vegnerà el vero Cristo [Verrà il vero Cristo]. Si guardi ancora un interno contadino: «Li’ travaduris negris, / li’ do’ sovàzis scuris, / li’ barconèlis quadris / cul vieri rot dai ùrlus / dei timporai tremendus…» [Le travi nere, / le due cornici scure, / le finestrelle quadrate / col vetro rotto dagli urli / dei temporali tremendi…], in debito con l’incipit di Viers Pordenon e il mont [Verso Pordenone e il mondo]: «A son restàs ta li vitrinis / i fis a vuardà cui vuj clars / in ta la lus da li cusinis, / sensa pí jodi i fogolàrs, / nè li tras infumantadis, / nè la tàula onta, nè i zèis / nè li dàlminis…» [Sono restati nei vetri delle credenze / i figli a guardare con gli occhi chiari / nella luce delle cucine, / senza più vedere i focolari, / né le travi nere di fumo, / né la tavola unta, né le ceste, / né gli zoccoli…]. Chel fantassút descòls intreccia l’infanzia favolosa, il trauma immedicabile dell’emigrazione, ma in coda alla raccolta installa Labalàda dei mèis [La ballata dei mesi], nel genere antico della corona, «una sorta di poemetto di rara intensità», «la prova d’un estro e d’una bravura squisiti» (Menichini), dove la scrittura si fa rapida, ariosa: «L’odula ’a cianta sui pras / e tai sgiavìns de menta…» [L’allodola canta sui prati / e sopra le testate ricoperte di menta…], con respiro spalancato, «Lievri. / Zenèvri. / Fun ta la cort. / Pons e castìgnis. / Zal dentra al bosc…» [Lepre. / Ginepro. / Fumo nel cortile. / Mele e castagne. / Giallo nel bosco…], nella totale libertà dell’elenco (e con passo da filastrocca), «‘Gu – gu – guuu!…’ la tortorèla; / ‘clac – cla – cla – cla!…’ la siàla in planta; / ‘zug – zii – zug!…’ la mos’cia blancia…» [“Gu – gu – guuu!…” la tortorella; / “clac – cla – cla – cla!…” la cicala sull’albero; / “zug – zii – zug!…” la mosca bianca…], in un trionfo di onomatopea pregrammaticale, che assimila ed elabora il paradigma pascoliano. Paradigma anche altrimenti attivo: «Chel ‘sisilìn’ / che ognun al se sint dentra / planzi / o ridi liegri / in sguòl serèn…» [Quel “piccolino” / che ognuno si sente dentro / piangere / o ridere allegro / in volo sereno…], che peraltro convive con la diversa e risentita rivendicazione: «Sì, jò suoi chel beat: / salt, onest!… / E me vanti» [Sì, io sono quel beato: / saldo, onesto!… / E mi vanto]. A. conosce la dolcezza suasiva del linguaggio figurato: «E la rosada ’a cianta / ’n ta li’ seris d’istàt / sot un ninsòul de luna…» [E la rugiada canta / nelle sere d’estate / sotto un lenzuolo di luna…], in un bisogno di trascendenza: «Sensa òus / ma col còur / e coi uoi / plens de sèit / de infinit…» [Senza voce / ma con il cuore / e con gli occhi / pieni di sete / di infinito…], nel fibrillare delle trame sonore. Ma in A. la critica ha avvertito «una poesia spesso impetuosa, dai moduli narrativi drammatici, tutta rotta, gridata, interiettiva, concitata» (Sgorlon), «un linguaggio franto, talvolta quasi singhiozzante» (Ciceri), «un tono liricamente alto, spesso concitato e drammatico» (I sielc’ peravali’), un «impeto esclamativo e travolgente» (Belardi), un «modo elementare, veemente, drammatico» (Faggin), e tali tratti sono flagranti in Come dal Purgatoriu, una silloge programmata sulla emigrazione: nella tenaglia della rabbia, della ferita, ma anche dell’orgoglio, «bandiera / par un Friul pì grant» [bandiera / per un Friuli più grande]. Il vocabolario del dolore si dissemina a piene mani, ma a imprimere i contorni dell’epopea: epopea aspra, ma comunque epopea. Assecondando l’effettivo processo storico, la raccolta si dirama in orizzonti via via più vasti: dai movimenti stagionali che contengono le loro peripezie nelle vicine nazioni europee all’avventura della Transiberiana, alla grande diaspora transoceanica, per riportarsi in ambito europeo, sforare di nuovo verso l’Australia, il Brasile, e fare infine tappa in Africa, avviandosi sullo scorcio dell’Ottocento, per esaurirsi nel dopoguerra, alle soglie dello sviluppo industriale. Una stagione archiviata nella realtà, ma viva e bruciante – e da tenere viva – nella memoria. Non astratta. La cadenza di nomi e soprannomi si dipana in litania, indice di appartenenza, vincolo con la comunità (che poi, a sradicamento avvenuto, si rovescia nell’insulto, ma si osservi come questo, privo di marche individualizzanti, si appiattisca nell’informe: «Dego», «macaronì», «Wog», microbo, in Australia): «Cussì, tal stali / o atôr del fogolàr, / Pascùt e ‘Scai’ / Ostàn e Toni ‘Slaipa’ / tal fâ ’na crùpigna / pal falsèt / un mani / o ’na cianaula / […] / al contava al contava…» [Così nella stalla / o attorno al focolare / Pascùt e “Scai” / Ostàn e Toni “Slaipa” / nel fare un’impugnatura / per la falce, / un manico / o un collare / […] / raccontava, raccontava…]. Nell’urgenza del riferire si fa ossessiva la determinazione locale, il martellare del toponimo in serie, a connettere i fatti e insieme emanciparli in chiave epica: «a Leoben / a Hamburg / a Stettin / o in Transilvania», «a St. Veit / a Hermagor / a Knittelfeld / a Linz e a Graz / in Stiria e in Carinzia», e così ovunque. E densissima è la catena degli esotismi, chiazze di colore e, insieme, parole-portafortuna, in grado di proiettare un paesaggio esotico e di tacitare lo smarrimento, di risarcire un io turbato. Nella galleria dei ritratti si stacca il protagonista di Mal d’Africa, parsimonioso nel dire, incapace o restio a sciogliersi in affabulazione. A questo personaggio senza voce succede conseguente lo spettro di Ciasa sbandonada [Casa abbandonata]: «Chi al speti / ’stu an / li’ sizilis a Sant’Isep / sot al portòn de ‘Strussia’?…» [Chi aspetta, / quest’anno, / le rondini a San Giuseppe / sotto l’androne di “Strùssia”?…]. I versi stringono ad anello il ricordo dei voli ubriachi delle rondini che un tempo affollavano l’aria, quando la casa ferveva, e la sagoma della casa ormai deserta, già controcanto dell’epopea: nostalgia di una stagione che prevedeva la partenza, ma anche il ritorno. E, pur se non sfuma l’alone della miseria, pur se non tace il sudore disumano, «Un scunîsi dì e nuot / da crevâsi la schena» [Lavorare giorno e notte / da spezzarsi la schiena], non sono contemplate (o ammesse, implicate) le voci della protesta. Coerentemente assume funzione ben altra rispetto a Leonardo Zanier (e al suo polemico Libers… di scugnî lâ, Liberi… di dover partire) il verbo «scugnî»: «Nol impuarta, fantàs, a’ se scui! Via-avanti!…» [Non importa, ragazzi, si deve! Via-avanti!…]. Un imperativo inoppugnabile, senza agganci storico-economici.